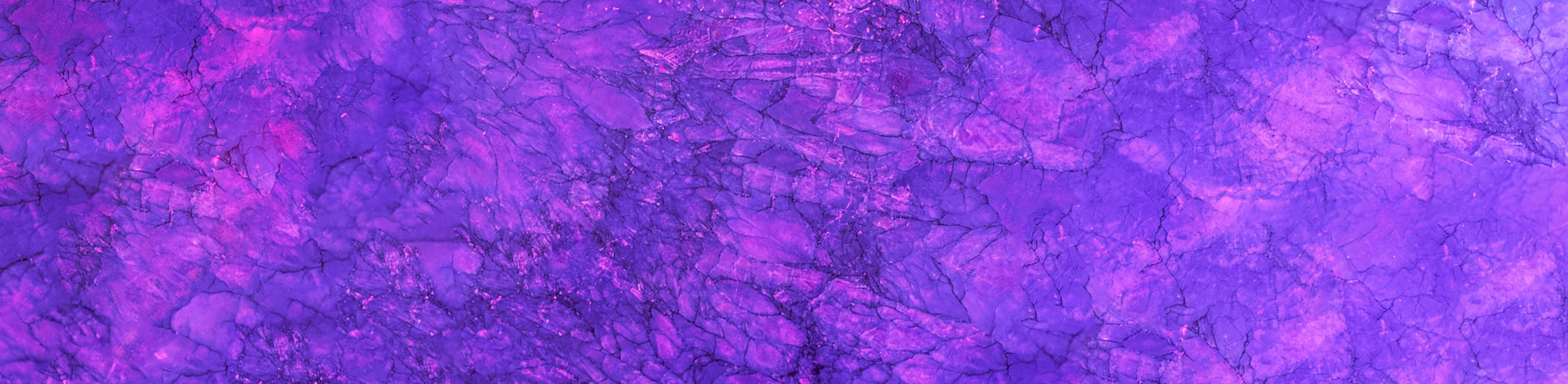Il Purpurissum è un pigmento artificiale impiegato fin dai tempi antichi per ottenere una tonalità porpora intensa, richiamando il prestigio della porpora di molluschi senza però sottostare ai costi elevati e alle difficoltà estrattive del murice. Realizzato nei laboratori artigiani di botteghe romane e medievali, serviva non solo a decorare superfici e codici di alto rango, ma anche a dare risalto a elementi sacrali e imperiali con un rosso-porpora resistente alla luce.
Origine e Produzione del Purpurissum
Sin dall’antichità, i maestri pigmentari romani cercavano un rosso porpora intenso capace di evocare l’autorità imperiale senza ricorrere alla costosa porpora di Tiro. Fu in questo contesto che nacque il Purpurissum, un pigmento “artificiale” studiato nei laboratori delle botteghe come soluzione economica ma d’effetto. Il cuore della miscela era costituito da due componenti fondamentali, macinate con cura fino a diventare polveri finissime:
- Cinabro (HgS) o minio (Pb₃O₄), scelti a seconda della disponibilità mineraria e del budget, fornivano la base rossa calda e coprente.
- Blu vegetale o minerale, come l’indaco estratto dalle piante o l’azzurrite (carbonato basico di rame), veniva dosato con precisione per spostare la tonalità verso un porpora profondo.
A questi pigmenti secchi si univano i leganti, un’arte a sé stante: gomma arabica per le miniature su pergamena, colla di pesce nei dipinti murali, oppure tuorlo d’uovo nelle tecniche a tempera. Il pigmento così preparato veniva impastato su una pietra d’agata, dove il maestro controllava manualmente la consistenza finché non otteneva una pasta vellutata e omogenea.
Esisteva una versione “di lusso” che prendeva la porpora di Tiro (estratta dal murice) come base e la arricchiva con polveri di lapislazzuli, granato almandino e corniola. Mescolando:
- Porpora di Tiro, come pigmento principale, per la sua luminosità unica.
- Polvere di lapislazzuli, per aggiungere riflessi violacei e regolarizzare la grana.
- Garnet (granato almandino) e corniola, per migliorare la profondità del rosso e conferire una brillantezza satinata.
Il procedimento prevedeva poi un periodo di “maturazione” in contenitori di ceramica smaltata, durante il quale le molecole del legante e dei pigmenti si stabilizzavano, assicurando resistenza alla luce e durabilità nel tempo. Grazie a questo riposo, il Purpurissum acquisiva quella profondità di colore e quella pienezza di copertura che lo resero celebre in affreschi, manoscritti e veli dipinti. Tra le caratteristiche tecniche più apprezzate vi erano:
- Finezza della grana, che permetteva dettagli minuziosi anche nei fondi scuri.
- Flessibilità di tono: variando la percentuale di blu nella miscela, si poteva ottenere praticamente qualsiasi sfumatura tra un rosso cupo e un porpora vivace.
- Adattabilità a diversi supporti, dalle pareti alle pergamene ai tessuti.
Questo equilibrio di materiali e passaggi artigianali conferisce al Purpurissum una doppia anima: da un lato, un’immagine di lusso in quanto “porpora del popolo” che imita la regale porpora di Tiro; dall’altro, un oggetto di studio prezioso per chi voglia comprendere l’ingegno tecnico e le risorse minerarie disponibili nell’antichità.
Utilizzi Storici nella Decorazione e nell’Arte
Fin dall’antichità romana, il Purpurissum fu impiegato come sostituto della porpora di Tiro nella decorazione di affreschi e mosaici, in particolare quando si desiderava conferire prestigio e sacralità a determinati elementi. Lo si ritrova in molte ville romane e domus pompeiane, dove veniva applicato per decorare pareti, tessuti dipinti e motivi simbolici.
In epoca tardoantica e medievale, il pigmento guadagna grande importanza nella miniatura e nella decorazione di manoscritti. Il fondo purpureo delle pagine (spesso ottenuto con questo pigmento) era riservato ai testi sacri o a codici imperiali, come si può osservare nel celebre Codex Purpureus Rossanensis, in Calabria, o nei codici bizantini realizzati su pergamena tinta.
Il Purpurissum veniva inoltre usato nei cicli di affreschi religiosi per evidenziare manti regali, vesti sacerdotali e dettagli iconici, specialmente in epoca bizantina e romanica. A volte, nei restauri moderni, la presenza di pigmenti contenenti piombo o mercurio ha permesso di identificare la presenza originaria del Purpurissum, distinguendolo da pigmenti più recenti o naturali.
Durante il Rinascimento, con l’arrivo di pigmenti più stabili e brillanti, l’uso del Purpurissum si ridusse, ma rimase presente nei laboratori artigiani per le sue qualità coprenti e per la capacità di modulare tonalità complesse nella gamma dei rossi e porpora.
Purpurissum – Un Viola Prestigioso
Il Purpurissum è un pigmento artificiale impiegato fin dai tempi antichi per ottenere una tonalità porpora intensa, richiamando il prestigio della porpora di molluschi senza però sottostare ai costi elevati e alle difficoltà estrattive del murice. Realizzato nei laboratori artigiani di botteghe romane e medievali, serviva non solo a decorare superfici e codici di alto rango, ma anche a dare risalto a elementi sacrali e imperiali con un rosso-porpora resistente alla luce.