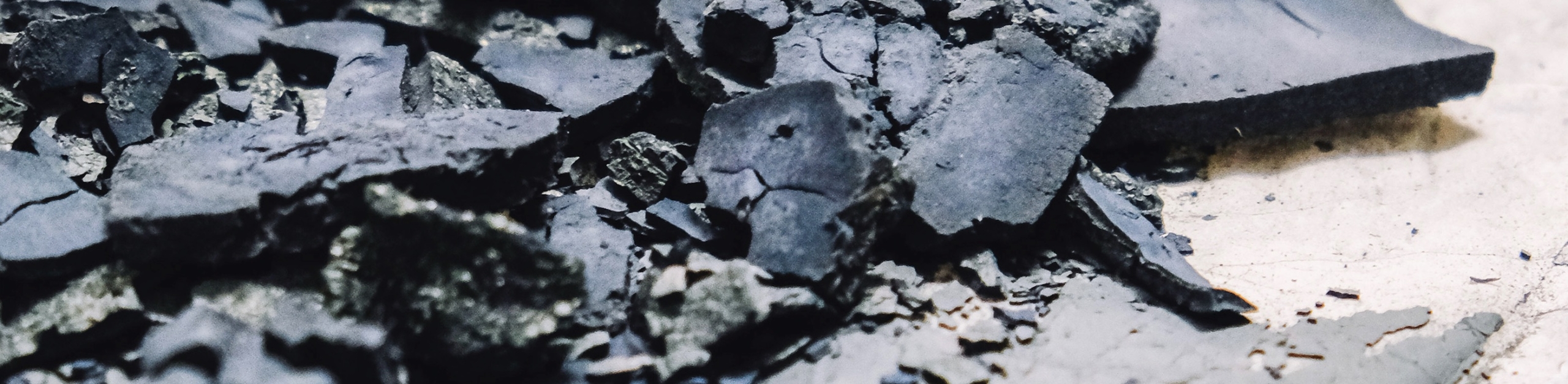Nell’universo dei pigmenti naturali, pochi evocano un’eredità culturale tanto vasta quanto l’indaco. Non si tratta soltanto di un colore, ma di un ponte tra civiltà, rituali e commerci che hanno attraversato secoli e continenti. Ricavato da piante tintorie attraverso un processo fermentativo sofisticato, questo pigmento organico ha lasciato tracce nel tessuto della storia umana: dai tessuti cerimoniali dell’India antica ai decori murali delle botteghe romane.
Sebbene l’indaco sia più noto per il suo impiego nella tintura dei tessuti, anche la pittura murale lo ha annoverato, in particolari contesti e con precauzioni tecniche dettate dalla sua natura delicata. A differenza dei pigmenti minerali, l’indaco è stato un alleato discreto: meno appariscente, più effimero, ma proprio per questo straordinariamente umano.
Estrazione e Preparazione del Pigmento
L’indaco si ottiene mediante un processo biochimico complesso, ma sorprendentemente efficiente, noto sin dall’antichità. A differenza dei pigmenti minerali, non si estrae da una pietra ma si “libera” dalla pianta attraverso fermentazione.Le piante più communemente utilizzate per produrlo sono:
- Indigofera tinctoria (Asia and Africa);
- Isatis tinctoria, conosciuta anche come guado, in Europa;
- Strobilanthes cusia (Cina e Sud-est asiatico).
Il procedimento antico prevedeva l’immersione delle foglie in acqua calda, che attivava la fermentazione. Dopo un periodo variabile, il liquido veniva ossigenato tramite agitazione vigorosa. Questo portava alla precipitazione della indigotina, il colorante blu, raccolta e fatta essiccare sotto forma di pasta o polvere.In Sicilia, Calabria e Puglia, il guado era conosciuto e utilizzato almeno dal XIII secolo, come attestato in documenti agrari medievali. È probabile che in queste regioni il pigmento ottenuto fosse impiegato anche in forma pittorica, specie per ritocchi su secco.
Indaco nell’Antica Roma e nel Mondo Asiatico
L’origine dell’indaco affonda le radici nell’Asia tropicale, dove piante come Indigofera tinctoria venivano coltivate e trasformate in pigmento già in epoca preclassica. In India, l’uso dell’indaco è testimoniato in manoscritti e pitture murali risalenti al periodo Maurya (IV-II sec. a.C.) e, in forma ancor più evidente, nei celebri cicli pittorici delle grotte di Ajanta (V-VI sec. d.C.). In questi affreschi buddhisti, l’indaco si affianca a rossi, ocra e verdi, offrendo profondità alle vesti e ai fondali.
Il pigmento giunge in Occidente grazie a reti commerciali antichissime. Già Erodoto (V secolo a.C.) menziona il commercio di una “sostanza blu” proveniente dall’India, mentre Plinio il Vecchio, nella sua Naturalis Historia (libro XXXV, 27), descrive l’”indicum” come un prodotto di provenienza orientale, utilizzato dai pittori per ottenere una tinta “blu scuro quasi nera”.
Durante l’età imperiale romana, l’indaco veniva importato via Egitto e usato sia in ambito tessile sia in decorazioni artistiche, probabilmente sotto forma di pigmento polverizzato miscelato a colle naturali o calce. In alcune case pompeiane sono stati individuati pigmenti blu non riconducibili a minerali, la cui natura organica è compatibile con l’indaco, benché i dati non siano sempre definitivi.
Nell’Asia centrale, l’indaco era largamente diffuso. Affreschi delle grotte di Bezeklik (Cina, VII-X sec.) e i decori buddhisti di Kizil (Xinjiang) rivelano un uso consapevole del pigmento, spesso accostato al vermiglione e all’oro. Anche in Persia e nel mondo islamico medievale, l’indaco era noto e valorizzato, soprattutto per la miniatura e la pittura architettonica su muro secco. La versatilità commerciale del pigmento contribuì alla sua diffusione, e la facilità di coltivazione delle piante indaco ne garantì l’approvvigionamento in regioni anche distanti dalla sua origine naturale, come l’Egitto, l’Anatolia e la Sicilia.
Impieghi Moderni: Un Pigmento di Nicchia tra Restauro e Ricerca Artistica
Nel contesto contemporaneo, l’uso dell’indaco naturale in pittura murale è raro e altamente specializzato. La sua instabilità alla luce e la scarsa compatibilità con le superfici alcaline come la calce lo rendono inadatto ai grandi impieghi decorativi attuali. Tuttavia, rimane oggetto d’interesse per una nicchia di restauratori, artigiani e artisti che perseguono approcci storicamente fedeli o sostenibili.
Nei laboratori di restauro filologico, il pigmento viene talvolta impiegato per il ritocco di superfici originali decorate con indaco storico, soprattutto in contesti orientali o medievali. I materiali naturali che lo accompagnano — colle animali, gomme vegetali, caseine — permettono una reversibilità ideale e una compatibilità chimico-fisica con i supporti antichi.
Alcuni atelier artistici indipendenti, specialmente in Giappone, Italia e Francia, continuano a coltivare e trasformare Isatis tinctoria o Indigofera tinctoria, producendo pigmenti in piccole quantità per opere d’arte contemporanea, libri miniati o progetti di bioarchitettura decorativa. In questo ambito, l’indaco assume un valore quasi simbolico: non solo colore, ma gesto culturale.
Un Pigmento Che Viene Dalla Natura
L’indaco vegetale, più di un semplice pigmento, racconta storie di legami tra civiltà distanti, di commerci e tradizioni che si sono intrecciate nel corso dei secoli. Dalle prime tinture nelle terre asiatiche fino all’uso decorativo nell’antica Roma, questo blu è stato testimone di un’arte che sapeva trasformare la natura in qualcosa di straordinario. Oggi, pur essendo meno utilizzato, il suo fascino resiste, soprattutto tra gli artigiani e i restauratori che ancora ne apprezzano le qualità uniche. Anche se l’indaco vegetale, per la sua instabilità e reattività, non è adatto per la pittura murale su larga scala, il suo impiego nelle tecniche moderne, seppur di nicchia, porta con sé la ricerca di un rapporto più diretto con il passato e con la natura stessa. Così, l’indaco vegetale continua a ispirare chi cerca di coniugare tradizione e innovazione, offrendo un legame tangibile con la storia e la bellezza del mondo naturale.
Sorgenti a Approfondimenti: beniculturali.it – Tonello.com – Soc.chim.it (pdf) – J. G. Strachan, Indigo: Egyptian to El Salvador, Archaeopress, 2000 – J. Kirby, Natural Colorants for Dyeing and Lake Pigments, Archetype Publications, 2017
Foto: albininext.com – officinadeisaponi.it – wikipedia.org